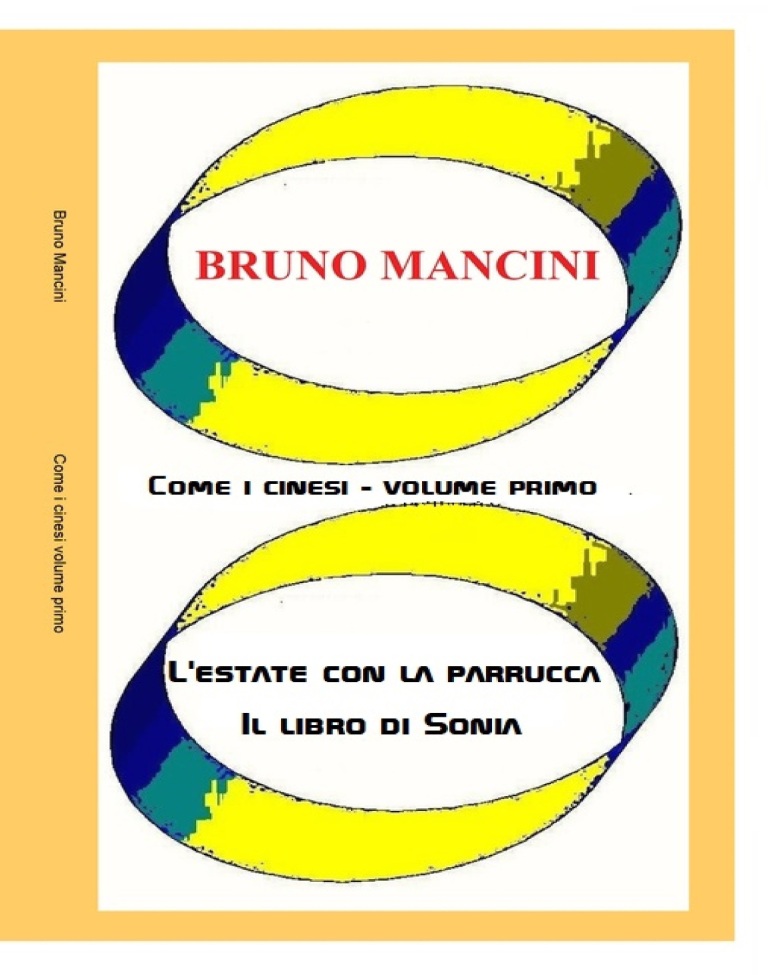
Views: 4
Come i cinesi -volume primo- L’estate con la parrucca – parte prima – capitolo 1
L’estate con la parrucca – parte prima – capitolo 1
Acquista il libro
L’ESTATE
CON LA PARRUCCA
PARTE PRIMA
CAPITOLO 1°
Esiste nella vita una sensazione chiamata notte.
Ad Ischia poi esiste anche un Bar con molti tavoli.
Uno è sempre occupato.
Il nostro.
Quanti ne siamo?
Chi lo sa.
Molti.
Chi siamo?
Chi lo sa.
Fratelli.
Da dove, da dove hanno inizio le vie a questo porto di tavoli e di notte?
Chi lo sa.
Dalla notte.
Ad Ischia esiste un tavolo che nella notte a macchia d’olio s’allarga alla strada di corpi.
La prima sera fu luglio.
-«Andiamo a cenare ai Maronti, vuoi venire con noi?»
-«Eh!»
Come ti sentivo dire di teatro e di letteratura e di cinema e di arte mentre ero vicino alla amica silenziosa e austera!
Tu parlavi ed io ti seguivo, e mentre mi facevi conoscere il tuo inverno, io cercavo di intuire la tua estate e tentavo di inserirmi in essa come presenza attiva.
Estate di uomini?
Estate di amori?
O forse estate idilliaca di contemplazioni?
Sulla spiaggia di individui assorti in penetrazioni di libri, in soste in chiazze di lampioni, all’alba, solo, sui marciapiedi con gli occhi alle cosce lisce e pelose, senza malizia.
Fu notte di prova.
Sapere cosa sapevamo saper volere.
Mi trovai da solo con lei e lei mi sfuggì.
Fuggì lontano nell’acqua nuda non vista, come vittima di un rito pagano, senza voltarsi e senza parlare.
La tavolata gridò gente.
Mangiammo prosciutto e bevemmo vino, bagnammo la pasta di vino, le gambe, la faccia, i capelli.
Di vino, di vino duro e lucente come i nostri occhi di febbre, nato con sforzi di piedi e di mani.
E noi eravamo in esso.
Eravamo nelle fatiche dei suoi padri buttati a raccogliere, finita la guerra, l’ultima cesta di semi.
Nei loro affaticati meriggi di agosto sulla china della collina sulla terra arsa e mossa in colpi di mani e di acciaio. Eravamo nei loro invisibili pianti, nelle loro mani di calli, sulle loro lingue asciutte, sulle fronti nere, nelle vite stanche.
Noi eravamo con fughe, sonni, amori, nel loro lavoro duro, noi, tutti.
Avresti voluto avere la forza di gridare “viva l’amore”, avresti dovuto avere il coraggio di stringerla tra le braccia ed amarla davanti a tutti senza vergogna, con passione. Avevo un desiderio enorme di ritornare a casa e dormire. Dormire.
Dormire per tantissime lunghe ore prive di coscienza; fino a ricostruire una giornata fondata sul nuovo perno di una nuova coscienza.
Ricerca.
Ossessione.
Attesa.
Ma non malinconia e noia.
Meglio tristezza atavica ed assurdamente sentimentale.
Se sono mare lambisco gli scogli e non riesco a possederli. Se sono cielo disegno stelle e non le vedo. Se sono uomo mi sento uomo e non ne godo.
Soffro lo zelo di vivere la natura.
Allora Enrico era centro.
Enrico, era falena intorno a Sandra.
Sua era la notte.
Creata per lui.
E lui ronzava con un forte rumore di irrequietezza.
C’era Sandra, così maliziosa.
Voleva divertirsi, ed io lo capii subito appena la vidi.
Fu un colpo magico.
Cinque minuti ed era al nostro tavolo.
Troppe mosche la infastidivano:
-«Ne prenderò una e con un piccolo splendido guinzaglio gliela regalerò, se permette.»
Poteva solo ridere e ringraziare.
Rise e ringraziò e fu bella e gentile.
Era quello il pomeriggio della discussione.
Venti o quaranta?
Io non ero pronto ad ammainare la bandiera dei venti anni così offrii una sfida.
Gli avrei presentata una ventenne graziosa, forse bella, e lui, lui stesso, unico arbitro, lealmente avrebbe detto poi se le sue preferenze continuavano ad aver valore.
Per Sandra era chiaro:
-«Una ventenne è sempre una ventenne, una quarantenne è sempre una quarantenne.»
Promessa o minaccia?
Resa o sfida?
Ironia o rassegnazione?
La mia serata finiva: Antonio accompagnava la Svizzera a casa ed Enrico accompagnava Sandra in pensione. Tu ed io ci ritrovammo ultimi a salutarci la buona notte.
I Maronti erano stati teatro?
Su quella spiaggia era soffiato qualcosa di simile al formicolio della carne troppo tempo riposata?
Avevano gli spiriti nostri compreso quello che le nostre vite richiedevano con insistenza lamentosa e pudica?
Che noi avevamo bisogno di amare, avevano saputo indurci a credere?
Troppe volte la consuetudine rende assurde delle posizioni e compromette tutto un sistema di vivere.
Troppe, troppe volte si diventa meschini e gretti per non saper spingere nel fondo di un mare di ridicolo il timore che una volontà intuita bella e santa e coerente sia contraria alle squisite norme della morale corrente.
“Morale corrente”? Quella cattolica apostolica romana. Allora sarebbe la “morale cattolica apostolica romana”: quella buddista o maomettana o zenistica no.
Allora è quella che “corre” da un individuo all’altro per adattarsi alle esigenze della loro ignoranza.
Vivere la notte.
Se ne passa un pochetto con gli amici, si ritorna a casa, si pensa per qualche minuto alla “morale corrente” e si deve fuggire a letto perché le cicale già gracchiano furiose.
La notte breve.
La notte del primo mercato.
Dette troppo fuoco alla mia immaginazione perché potesse rimanere un fatto.
La loro cultura di nomi papaveri, di “C’ero pure io”, di date incerte.
Mentre Renato recitava l’attore preso da tutte le forme modeste di vita:
-«A me,» molto nasale e con le mani protese avanti quasi ti invitasse a raccogliere il sorriso-bontà di cui aveva costretta la faccia ad essere impastata «a me non m’importa niente dei soldi, capisci, che vuoi che m’importi. Io non ne ho, non ne ho, guarda non ho una lira io.»
E andava e veniva da grossi barconi.
-«Che hanno pescato?»
-«Dei pesci grossi così, dei bei pesci, vieni a vedere, è teatro questo vedi.
Tutto è teatro.
Tutta la vita.
Guarda quella finestra.
È teatro.
E noi che siamo?
Teatro.
I soldi, la gente pensa ai soldi, si uccide, capisci si uccide per i soldi. Io non ne ho» e sorrideva «che vuoi che m’importi dei soldi.
Guarda quel carretto, queste bucce di melone, quei pescatori, quei pochi pescatori innamorati del mare.
È teatro tutto questo.
Tutto è teatro.
E noi, perché, credi che noi non siamo teatro?»
-«C’ha ragione, vero Bruno?»
E alcuni aspettavano di pronunziare un nome importante per dire che era loro amico, o che una notte c’erano anche loro, e che quella grandiosa la fecero “Non ricordo bene forse il dieci. O il trenta? Bah che importa.”
Per me seguirli e non affrettare altro che immagini.
Come quando si fuggono in macchina ruderi e monumenti di paesaggi e di cose, di arte o di storia.
Quella piazza a bagno d’onda accesa da lampioni da molo. Quel fondo scuro ed insignificante: sagoma notturna e senza forma del vecchio baluardo Aragonese.
Quei lastroni di pietra grigia durissima, ad incastri strani
perduti dove non ancora la piazza è strada incisa tra file di vecchi palazzi addossati con archi, finestre, portoni, rosa, polvere, verdi, celesti, gesso.
Appoggiato largo o steso sul parapetto a mare, come fisso in contemplazioni di stelle o come immerso in pensieri casti e sereni, ciascuno aveva dentro il suo silenzio: profondo come il mare fermo a raccogliere le nostre pietre in rapidi gorgheggi, scacciato a volte come un corvo, e come un’onda, pronto a ripresentarsi pallido.
Dissero:
– «Andiamo!»
-«Tutti al mercato!»
-«Al mercato?»
-«A quest’ora?»
-«Si venite.
Li mangeremo uva e compreremo uova e parleremo a vecchie donne campagnole madri di venti figli, e ci apriranno dolci le loro terre, le loro vacche, ci mostreranno mani ruvide di solchi proprio come le loro terre e i loro occhi senza sonno, e capirete cosa vuol dire l’ora dei capponi.»
-«Andiamo, venite.
Fa presto salta, andiamo tutti a bere uova fresche di giornata.
Dai dai parti e corri.»
C’erano cento ceste e cento donne. Dai volti scarni e bucati.
S’alzavano di notte per scendere al mercato.
Cinque chilometri a piedi con ceste pesanti di frutta.
Pagare pochi soldi pesche gialle e uva e uova, ed essere nelle tenerezze e nelle tristezze della campagna, sarebbe diventato per me una necessità e ne avrei formate schiere di proseliti.
Appuntamento alle tre al bar, e via al mercato ed al forno
-avevo infine saputo dopo sedici anni che è possibile trovare il pane caldo di notte- a mangiare pane e uva e bere seduti indisturbati nel centro della strada le ultime birre della giornata.
Fino all’alba a stupire quei vecchi quanto fossimo mattinieri.
-«Dei signure commé e vuie a quest’ora!»
-«Nonna vuoi un po’ di birra, bevi è buona, e dai non è mica veleno, è fatta di paglia, io ne bevo pure venti al giorno, e tu bevi solo vino?»
-«Acqua e vino»
-«Ma più vino che acqua.»
E tutte le vecchie ridevano.
-«Tu sei suo marito?»
-«Signorsì.»
-«E tu pure bevi acqua e vino?»
-«Io so cinquant’anni che nun conosco l’acqua. L’acqua mia a fa ‘a vigna.»
Così fantasticare diventava vivere.
E vivere poetare.
Renato una notte sceglieva le uova e beveva birra, tu ed Annabella più dietro, io vi chiamavo ad udire:
-«Ed io ti parlerò di cani e di animali
delle mie pallide albe di sconfitte
di ore mai vissute
di stelle,
ed io ti creerò bellezze
e ti richiamerò ricordi.
Renato, Renato ti piace?»
-«Quanto vuole quest’uovo?»
-«Renato, senti come è vibrante: “ed io” -in tono enfatico- “ti parlerò di cani e di animali.” Di cani e di animali, ti
piace?»
-«Quanto me la fa pagare questa pera signora?»
-«L’ho fatta ieri notte… e senti»
-«E questo pomodoro?»
-«Delle mie pallide albe di sconfitte»
-«Ma vendete molta frutta qui la mattina?»
-«di ore mai vissute»
-«E chi è che le compra a quest’ora?»
-«di stelle,»
-«Gli alberghi, le pensioni, tutti quanti.»
-«ed io» -più forte, strillando- «ti parlerò di cani e di animali»
-«Però deve essere interessante, vero signora?»
-«ed io» -quasi senza voce- «ti creerò bellezze e ti richiamerò ricordi.»
Non sempre riuscimmo a “creare” le nostre ore, tu ed io. La musica, l’aria, il succo di pomodoro, i fantasmi, l’ora. “L’ora dei fantasmi”: quando le immagini e le esaltazioni, ultime o antiche, richiedevano attenzione in ugual misura.
“Creare”.
Allora confessavamo spavaldi, stanchi e vecchi -decisi comunque a non lasciare guizzare, sotto il fumo grigio di proposizioni austere e meditate, e del parlare serio e sentito, nessuna frivolezza di un quarto d’ora precedente- la volontà di bere gli altri; non di distruggerli, di berli, di gustarli, di dare a noi stessi un senso di piacere dalla valutazione delle loro essenze; non di giudicarli, ma sceglierli per formare mosaici di pezzi viventi, assolutamente particolari, strettamente personali.
Quasi volessimo tramutare, così, la storia in arte, e a nostro uso, la scienza in gioco.
-Sai di cosa mi sono accorta?
Che l’uomo non potrà mai provare, perché non c’è l’equivalente, l’esperienza di una donna intelligente con
un uomo bello ma sciocco.»
Le pause lunghe, gli sguardi fissi e d’improvviso vivaci poi ancora fissi, le mani a strisciare il vetro dei bicchieri.
-«Il rapporto uomo intelligente-donna bella ma sciocca, e tutta altra cosa.
Considerando, naturalmente, la donna intelligente del primo caso e l’uomo intelligente del secondo, uguali per valori estetici e per sentimenti.»
Tacevo sorpreso e contento: ecco un problema quanto mai generale e sconosciuto!
Certo deve essere differente.
Una cosa è una donna bella ma sciocca, ed un’altra è un uomo bello ma sciocco.
Un uomo bello ma sciocco per una donna intelligente. Cos’è?
Non può mai essere come una donna bella, bella!
Per un uomo.
Anche se non intelligente.
L’uomo ne può fare a meno.
-«Hai ragione, il rapporto è diverso; però non sono convinto che non esista l’uguale.
Non posso ammettere che l’uomo debba essere mutilato rispetto alla donna di una sensazione.
Abbiamo già una costola in meno.
Una sensazione poi, eh no, è troppo.
Certo che è strano, apparentemente è come dici.
Dove si trova un rapporto inverso così fatto!
L’uomo dovrebbe essere in grado di vivere con una donna in una dimensione tale che nessuna donna abbia la possibilità di sperimentare.
Ma ecco, è così!
L’uomo masochista e la donna sadica.
È lo stesso!
Però è difficile, credo che mi sarà difficilissimo spiegarlo. Non so nemmeno da dove iniziare; eppure è così, lo vedi?
Lo riesci a vedere?
Uomo masochista-donna sadica, come donna intelligente-uomo bello e sciocco.
Ma ci riuscirò, ancora un momento.
Come dire che bisogna fare una distinzione.
Il tuo caso è un caso di sensazione dovuta alla mancanza di un attributo essenziale da parte dell’oggetto che la genera.
E l’attributo è l’intelligenza.
Infatti l’uomo è generalmente considerato più intelligente della donna.
E questo attributo è invece amplificato nell’elemento che subisce la sensazione, nella donna.
Nel mio caso, ugualmente manca all’elemento che subisce la sensazione, alla donna, un attributo essenziale cioè il masochismo, e questo, si riscontra nell’oggetto che subisce, voglio dire nell’uomo.
La donna non potrà mai provare l’esperienza dell’uomo masochista con una donna sadica, perché anche qui ciò che dà un volto alla sensazione, capisci, è la mancanza di un attributo, il masochismo, che generalmente è proprio delle donne.
Ed anche qui esso si sposta nell’oggetto che subisce la sensazione. Inoltre è evidente che l’originalità, nel primo caso è fatta capire alla donna proprio dalla sua intelligenza e nel secondo è rivelata all’uomo dal suo masochismo. Insomma è come dire che per mezzo dell’intelligenza la donna può vivere, nell’intelligenza, un rapporto di cui l’uomo può avere consapevolezza nel sentimento solo se è capace di una volontà di soffrire.»
Bisognava riflettere ancora, proporre, discutere, farsi belli di quella scoperta e di quella risoluzione, mettere tutti davanti al problema e vederne -berli- le reazioni e le risposte.
Come quando ci sedemmo, sempre tu ed io, sul
marciapiede e chiedemmo a tutti i giovani passeggiatori della nostra età a bruciapelo:
-«Solitudine o isolamento»
-«Ma in che senso?!»
-«Solitudine o isolamento»
-«Solitudine»
-«Solitudine o isolamento»
-«Isolamento»
A volte era l’indice a spostarsi da un volto all’altro additando.
-«Isolamento»
-«Solitudine»
-«Solitudine o isolamento»
-«Compagnia»
-«Solitudine o isolamento»
-«Isolamento, isolamento»
-«Solitudine»
-«Isolamento»
-«Solitudine o isolamento»
-«Ma che vuooo!»
-«Isolamento, isolamento».
A che serviva.
Che valore aveva.
Perché?
Ma a che serve prendere il sole, dormire, nuotare, leggere, cantare, strillare, pregare.
A che serve amare. Potevo dirti questo.
Potevo dirti tutto quanto sorgeva e moriva.
E le banalità e le piccole azioni inutili prendevano un volto severo, grave; si immettevano in un passato di lotte e di conquiste.
-«Ho visto Cinzia!» -tutto un castello cresceva di un pezzo -«M’aveva chiesto se poteva sedersi a scrivere una
lettera»
senza di te non aveva valore
-«… e le ho scostata la sedia con un movimento di piede. M’ha detto: “Mio padre è partito, ritorna domani pomeriggio”.»
Era un vanto e ne avrei potuto ridere, ma con te presente diveniva uno studio ed ero serio, compresso.
.«Ed io: “Ah bene”. Senza significato.
E poi lei: “Che hai fatto?”
ed io: “Il solito.”
“Sei ancora arrabbiato?”
“Insomma senti, se quelle cose le hai dette sul serio, allora ritorna quando avrai cambiato idea nei miei riguardi, se poi volevi scherzare, allora ritorna quando avrai capito che è un tipo di scherzo che non mi piace.”
“No, io lo pensavo veramente.
Quello mi aveva fatto arrabbiare, e ti giuro che se non c’era lei glielo avrei detto ieri pomeriggio invece di aspettare ieri sera.
Mi ha trattata proprio come una di quelle.
Ma per chi mi ha presa.”
“E te la prendi con me!
Tu sei proprio una sciocca, una bambina.
Come l’altra volta, loro inventarono favole o sparlarono, come preferisci, e tu te la prendesti con me.
Sei matta.”
Continuava a scrivere lentamente “Caro Italo… ” e non avrebbe voluto finire mai.
Quando già si trovava lontano una decina di passi: “Cinzia, senti,” mi è venuta vicinissima col grosso bel viso pieno di capelli biondi e di odore di giovinezza, ed io ho continuato in un sussurro: “se cambi idea sai dove trovarmi.”
La guardavo. “Credevo fossi arrabbiato e non mi volessi
più vedere.”
“Alle sette.”
“Qui?”»
Le dita respiravano volute d’aria ed annebbiavano ed aprivano ricchezze di luci e di forme. Scioglievamo volute d’aria come tavolozze rosate.
Guarda lontano, più lontano che puoi, oltre la scura striscia della riva, oltre quel muoversi bianco e verde e bruno del mare che si rompe, guarda al di là dell’isola sfumata di celeste, più lontano che puoi.
Salvatore Quasimodo:
*A ciglio dell’isola il mare era sale;
e s’era distesa la terra e antiche
conchiglie lucevano fitte ai macigni
sulla rada di nani limoni.
E dissi all’amata che in sé agitava un mio figlio
e aveva per esso continuo il mare nell’anima:
«Io sono stanco di tutte quest’ali che battono
a tempo di remo e delle civette
che fanno il lamento dei cani
quando è vento di luna ai canneti.
Io voglio partire, voglio lasciare quest’isola».
Ed essa: «Oh caro, è tardi, restiamo.»
Allora mi misi lentamente a contare
i forti riflessi d’acqua marina
che l’aria mi portava sugli occhi
dal volume dell’alto veliero.
Non sai di quando, appiccicata di sabbia, la mano rimase ferma davanti al suo volto, col dorso, lungo, di
vene e di peli e di ossa. Ferma un interminabile silenzio.
Poi le dita, come viventi, presero a mostrare pianissimo il loro risveglio e lei guardava, e la mano si mosse: “Io sono stanco di tutte quest’ali” e pose le cinque dita sulla sua guancia, vicino alla bocca, sulle labbra.
Il viso fu sabbia.
Premeva e si scostava.
Sabbia.
Sole.
Vita.
Giovinezza.
Fu un bacio e un tutto.
Oltre quel lungo spigolare la pigna d’uva robusta e verde dei nostri pensieri di vita.
Robusta di chicchi, robusta ma acre, imperfetta ma forte, ed agre a mangiarla e mangiata agre perché attendere altro sole può essere attendere invano.
Noi ci offrivamo i chicchi di ore ed ore. Ed erano uguali: agri, diversi, robusti.
Noi siamo carne, e la carne lasciarla lisciare dal vento sottile di montagna.
Senza pudori.
Senza ingiustificabili abissi di verginità.
Affiancare vita alla vita, una mano e una mano, al vero il piacere.
Noi siamo sensualità, e la sensualità lasciarla scorrere tra le righe scavate dai rastrelli nella rena stanca di un giorno. Senza rimorsi.
Noi siamo mente, ed aprirla allora la mente alle voci e ai contatti.
Senza inibizioni, senza cautele, senza speranze, senza consuetudini.
Così appare la nostra ombra e nuvole di diverse lontananze, e così tu potrai essere il tuo uomo e potrai stringere forte ed unico la tua donna silenziosa, così tu sarai sangue, e non più lacrime e non più ira, solo sangue rosso in uno spazio infinito.
-«Io faccio sempre quello che voglio, perché non m’importa niente delle cose. Qua dietro» e le indicavo la porta della cabina alla quale eravamo appoggiati «sono venuto con tantissime donne, ma nessuna che l’abbia in qualche modo costretta con azioni o con parole.
Tutte libere.
Tutte dovevano sapere che venivano perché volevano venire, ed io più di loro.
Devo essere sicuro che non ci siano dubbi, che sanno, tutti coloro che fanno un’azione nella risoluzione della quale ho preso in qualche modo parte, che sanno che la attuano perché la vogliono.
Solo così si vive senza rimpianti; ed io non ho rimpianti, nessuno.
Vivere senza rimpianti vuol dire proprio vivere così, sempre presenti, consapevoli sempre di agire seguendo la volontà più forte, e quindi più desiderata.
Cioè: “Capisco che faccio ciò che mi piace”.
In questo modo i rimpianti non esistono.
Non si può essere tanto sciocchi da provare delusione nel rendersi conto che il viale alberato si tramuta in mulattiera acciottolata, e rimpiangere per ciò i metri percorsi.
Il viale per noi cessa di essere tale solo quando lo si capisce viottolo, e la delusione, quando c’è, è causata da una diversa consapevolezza: sentirsi estraneo, sentirsi non più presente, sentirsi incapace di generare una nuova volontà e di seguire quindi un cammino conforme al nuovo stato d’animo.»
-«Ma questo è edonismo, è una forma di edonismo spirituale, è egoismo che allontana ogni valore universale.
È la mente singola che egoisticamente vuole dipendere solo dalla sua stessa volontà e vuole esistere solo per se
stessa.
È narcisismo.»
-«Certo è egoismo, è edonismo, è narcisismo, è, posso aggiungere, un modo per non mettersi continuamente in discussione.
Ma solo per coloro i quali non sentono la bellezza della ricerca, o per chi non ama il valore di storicità e non è fatto vibrare da nessun “fuoco eroico dell’ideale”.
Perché altrimenti, per me, per te, la bellezza della ricerca ci porterà ad inseguire ed a raggiungere sempre nuove e più vere verità; ed il valore di storicità ci farà immedesimare con tutto quanto c’è di più universale socialmente ed eticamente; e tu, vibrando per “l’ideale” ti sentirai appagata per ogni tuo pensiero e per ogni tuo sentimento.
Allora una vita, la tua, tutta, sarà posta davanti al Vero, al Bello, all’Utile, all’Etico.
Certo con egoismo, con edonismo, con narcisismo, ma questo vale con forza, con passione, con sicurezza.»
E con te mi venivano le mie estati passate.
Quella estate.
Quanti inverni hanno macchiato i muri dei nostri palazzi. Quante volte ho rivisto gli amici di quella fanciullezza.
Gli anni si sono aggiunti agli anni, ed ora guardo, e se capisco, non soffro, se mi fermo, non tremo.
Quella estate.
Ritrovare un ricordo, e non sentirlo estraneo per poterlo stringere, e stritolare e farlo cessare di esistere.
Non volevo assolutamente niente.
Neanche mi ponevo il problema di esistere o, che forse per alcuni aspetti è equivalente, di guardarmi attraverso la voce mia e non quella di una scuola, di una famiglia, di un ambiente, di una società, di un mondo che allora non vedevo neanche, sebbene per diversissimi e più o meno
alti ideali, colpevole di asfissia.
Un’intera esistenza può vederci marcire nella miseria del corpo e dello spirito, ed un attimo ci può liberare
dall’inferno.
Milano, così rigida per una mente giovane, per un essere nuovo di esperienze anche se impastato di storia e di letteratura, diventava addirittura fantastica nel mio desiderio di incontrare un viso che la nebbia tenue e sfumata, ero certo, avrebbe di lì a poco accettato di mostrarmi sorpreso e felice.
Svegliati embrione, fiorisci.
Nella sera di primo caldo la vidi e la persi.
Mentre pioveva la vidi venirmi incontro:
“Ciao” sempre solo “ciao”.
“Ciao”.
Dov’era la mia donna?
La mia compagna la sentivo nuda in una gialla cabina piangere di pudore e di gioia mentre gente inutile passava e non sapeva.
Era stato proprio amore.
Certo.
Amore nella forma più elementare.
Più vicino al cuore e più staccato dalla gente.
Ora, vicino, mi trovavo quel ricordo e temevo, ancora prima che lei lo rendesse staccato dal presente, privo di continuità e senza volto, temevo di doverlo sopportare da solo, di potermi scoprire, un giorno, intento a farlo rivivere senza la certezza di non essere solo, con la certezza di essere solo.
“Non ti amo più.”
Ci guardammo tanto; senza dire una parola.
Gli occhi che quasi riuscivano a stabilire un contatto fisico e le labbra immobili.
Avrei potuto trovarmi al centro della terra tanto era la spinta delle lacrime verso la libertà.
Ma non potevo.
Già una volta avevo pianto.
Vivere trovando ragione di lutto nella forza, e non salvezza nella pietà.
Tutto uguale all’ieri eppure tutto diverso, tutto smarrito e ritrovato, guardato e visto volare attraverso le dita.
Unica meta, unico abbaglio, unica colpa, unica causa.
E poi io, io, io, io solo e il mio passato ci trovammo a guardarci ad occhi sbarrati dallo stupore e dallo strazio quando venne la prima ora notturna e non c’erano per le strade facce conosciute.
Nessuno quel vagare poteva intendere.
Ormai l’esistenza e la convivenza si ponevano come problema, per la prima volta, soffiati dalla mia incapacità di raggiungere le vette candide e gelide dell’io solitario nel dolore e nell’amore.
Nessuno poteva intendere che quello era un viso stravolto. No, non avevo un viso.
Non sentivo.
Cosa potevo.
Volere.
Lei, lei si.
Avrebbe potuto.
Poteva.
Ma col tempo.
Tempo di lotte indefinite.
E così venti ore di studio al giorno con l’attesa nel cuore, col pensiero che fugge attraverso i campi del sogno e con la disperata necessità di riportarlo ai libri, di associarlo al tutto si trasformavano in pena di vedersi promossi e di sapersi falliti, di ricevere strette di mano e desiderare nascondere la faccia in un seno amico e voglia di piangere e piangere ed essere confortato: l’angoscia di sentirsi solo, solo, solo solo, di sentirsi solamente un essere solo.
E poi, dover riprendere a vivere, e, vinto, essere preda torturata, abbattuta, mai uccisa, e dolersi, e dolersi, dolersi; continuamente dolersi senza poterlo dire, senza saperlo dire.
Nude membra nuotarono nell’azzurro bollente e sereno d’agosto, mentre di notte, lontano, un tremulo trillo di tromba salutava l’aurora.
Invito alla danza.
Piedi scalzi e scagliosi crearono rivi di terra compatta; tra canti soffici l’uva bruna, l’uva bionda riempiva canestri di paglia.
L’uva diventata vino scorreva bagnando gole asciutte, fino a deliri.
Le strade calate in una visione immensa, il cielo inesistente. Era infinito quel fluire d’ore pigre attraverso la mia mente rimasta fanciulla nella spietata rinunzia di un volere non gradito.
Mille notti preghi un dio cui non credi; che detesti nella sua crudeltà di esserti lontano, staccato; “Ancora un giorno e poi basta.
Lo credo.
Ne sono sicuro.
Domani.
Verrà tra poco domani e me ne andrò diverso sulla stessa spiaggia che oggi ho odiato, e potrò cantare belle canzoni dolci.
Per me.
Per me solo.
A me solo.
Certo, certo domani non vedrò più formiche morire su lucide distese di cemento, domani esse cammineranno senza bruciarsi; perché domani ci sarà il mio sole a risplendere là su.
Ed è buono.
Lo so bene che è buono.
Sicuro domani vedrai che non verranno tristi pensieri d’ignoto, e capirai le sue distese verdi di piante e di erbe, e per te saranno verdi e saranno fioriti i rami nei burroni e sulle rocce di lava scura ed impetuosa.”
A sollievo il sonno. Al sonno, l’uguale debole rifiuto.
Per un’estate continua fino ad un inconsistente abbraccio con una finzione che, vera -miracolo- era foriera di sonno.
Così venne settembre.
Nell’aria immota torreggia l’agonia de sole.
Qualcuno -forse lei?- mi disse: “Chi sei?”. “Io sono Bruno” risposi.
Qualcuno mi disse: “Sei vivo?” risposi “Forse un giorno ancora”.
E una turba di sogni, illusioni, affetti, impossibili, informi disumani mi trapassò nell’ozio.
Io aspettavo che l’orologio di una chiesa suonasse quell’ora e poi entravo: il viale, il portone, le prime due serie di scale, il terrazzo, ancora più su e poi la vedevo immobile dietro l’angolo della vetrata ed allora… dio, era magnifico, era tutta la vita.
Ferma vicino al muro, nella penombra che non riusciva a nasconderle il sorriso.
Serena agitazione, paurosa gioia,amore,sfrenato possessivo illimitato superbo e candido sentimento di bellezza.
Lì, potevo far di lei una schiava, una misera schiava e invece la veneravo dea dei miei pensieri; potevo carbonizzarle l’anima al fuoco acerbo della mortale indifferenza e la incoronavo sogno della mia vita; potevo spogliarla di tutto -anche del desiderio di tentare di nuovo una vita- e ponevo nelle sue bianche mani gli anni passati, i giorni presenti e tutti gli istanti futuri.
Ed ho impresso sul suo petto la gioia di amarla mentre i suoi occhi erano parole d’eterno.
Tante volte, mentre il calore della sua carne bagnava il mio corpo inerte, cercandole gli occhi le chiesi: “Non lasciare ch’io tocchi la tua pelle, non legare la mia vita con un bacio, se domani potrà essere un ricordo; io ti chiedo
d’amarmi come solo si ama l’eternità”.
Amare lunghe notti se or di voi solo rimane un grido e se ritorna sempre presente il ricordo di incomprensioni.
Sempre che, nel silenzio senza tensione, mentre i nostri due indici, non visti, creavano sulla pelle fantastici disegni, quando sentii prepotente il bisogno di farle intendere che amarla era qualcosa di bello e di purificato e di divinizzato da un immenso sentimento: “Sai, ad amarti non provo vergogna”, non capì che per me neanche esiste persona con la quale sia possibile dire che è vergognoso fare l’amore, ma che invece ci si può vergognare di baciare una santa.
E poi che, l’ultima volta: “Tu non ha fatto niente per farmi innamorare di te”, perché avevo un bisogno interiore e quasi una necessità fisica di sentirmi immerso nelle mie azioni.
Credé che la stessi accusando di non avermi amato, e si allontanò sembrandole che mentissi senza pudore.
Suoneranno ancora le trombe di Gerico ed a crollare saranno le mura erette dall’umanità a difesa della sua natura sospettosa, testarda, incapace di recepire messaggi e situazioni diverse da quegli schemi che di volta in volta, nella sua vita individuale, ha valutato ed ha accettato.
Con te, parlavo di quella estate lontana dalla nostra quanto l’uomo e dio.
Lontana?
Perché lontana?
Perché nella nostra le ho detto “Io credo nella verità nella sincerità disinteressata, credo in te Annabella”, per questo? Certo, era vero. Io credo nella verità, nella sincerità disinteressata, credo in Annabella, ci credo ancora, forse per l’ultima volta, ma voglio ancora crederci.
Ma quella tristezza non era altro che questo credere; quella pena, questa sincerità; quel dolersi, dolersi continuamente dolersi senza poterlo dire senza saperlo dire, questo “Forse per l’ultima volta, ma voglio ancora”.
Hanno solo subito il passaggio dall’uomo, all’uomo che smette di soffrire.
Dal giudicare ad un’azione resa meccanica e perfetta.
Il timore che diviene speranza.
L’angoscia che diviene sogno.
Tutto passa e rimane.
L’uomo.
Dio.
L’uomo è dio.
Solo che lo voglia.
Come accade al timore.
Solo che abbia l’incoscienza o, se vogliamo, il coraggio di uccidersi della morte appropriata.
Bisognava essere più forti della propria tradizione, più gelidi della propria storia, più chiari del proprio passato; e bisognava andare alla scoperta di nuovi scogli.
“Cosa farò?” “ Cosa sarò?” “La vita scorre” “Non basta una mano ad arrestarne il corso” “Ma anche io sono vita! Allora anche per me e la mia vita non deve bastare una mano, non deve, non deve assolutamente bastare una mano, cioè un fatto, qualunque esso sia”.
Come in un gioco di specchi appare Annabella e poche inaspettate lacrime, mentre cercava estirpare i suoi perché; non parlava chiaro, né diceva pensieri completi: “Quando
sto lontana… e poi”.
Non era questo il mio desiderio, né il pianto né l’ignoto.
Bagnato di freddo di pioggia di fine estate, dovevo brancolare parole di conforto, vaghe.
Annabella.
Diventammo crudeli.
Ciascuno con se stesso.
“Se fossi tutta una montatura?”
Non ricordo di aver detto niente, ma solo di averla guardata imperativo, e se sentiva le mie voci certo sentì quel grido lungo di protesta.
“Sì mi sento proprio una pagliaccia.”
“Io lo sono.” Via sotto la pioggia.
Ma chi era?
Da quale profondità era venuta a volare sulle mie spalle ed a beccare nella mia mano briciole di esistenza diverse -negli affetti- e con le briciole, la mia carne, in sofferenze?
“Sto sognando”. “ Ho sognato”. “Tutta la mia vita bella passata è stata un solo lungo sogno”. “L’amore è un sogno ed è un sogno la donna che l’ispira”.
“La vita è un sogno ed un sogno è la donna che ti fa credere in essa”. “Un sogno è la fede, il sogno è un dolore”.
L’Olimpo fuggiva.
Tutta quella nullità. Quel paradiso dalla bella piccola nuvoletta al sole. S’apriva la vita con le sue sconfitte, con i suoi dolori, con i suoi urli di bestie ferite.
I fantasmi.
A mezzanotte in punto.
I miei fantasmi compaiono e m’invitano nel loro viaggio senza tempo.
Ed io sempre a seguirli in immagini, e ad accettare le loro carezze di suoni e di pensieri e di sguardi e di affetti.
Come sfuggite al tempo.
C’è l’altro fantasma, con la sua veste, con la sua tristezza e
con la sua voce.
L’immagine si ferma ed è un quadro che io avevo già visto. Li avevo già visti tutti.
Avevano camminato con me.
Piano, piano-piano.
Con me sulla nave e sulla terrazza e su ogni pietra e su ogni muro e sulla spiaggia.
Quante inutilità scomparivano!
Quanti ricordi in quel fuggire ore vissute!
Con i mie primi fantasmi una voce “Non hai il diritto. Non puoi.
Non devi togliere agli altri l’immagine che avevi accettato di donare, le tue tristezze; i tuoi pensieri cupi, sciocchezze, sei ladro, ladro e vile!
Tu l’hai offerta per anni uguale.
Essi l’hanno presa.
Tu vuoi cambiarla.
Essi non sanno desiderarla diversa.
Tu non puoi, tu non devi, tu non hai il diritto, tu non desiderarlo, tu non farlo, tu non puoi, tu non devi tu tu tu tu tu.”
“Non posso.
Non devo.
Non ho il diritto.
Me stesso.
Fuggiasco.
Quello.
Passato.
Vile.
Ma perché?!
Ma di cosa?
Perché devo essere fuggiasco?!
Vile fuggiasco di me stesso.
Vile.
Vile.
A nascondermi.
Per quello.
Non ho il diritto di cosa?
Di vivere?
Non ho il diritto di vivere?
Non ho il diritto di mostrare la mia vera volontà di vita? Devo desiderare qualcosa di più oscuro, di più lontano, di più impersonale, di più disumano?
La mia rinunzia.
A me.
Che ora sono.
Dolorante distruggere.
È impossibile vivere così.
Quest’ansia continua di buio.
Debole.
Afflitto da una vita e non, dalla vita.
Macerazione.”
Da quattordici giorni cresceva continuamente in me.
La vedovo calcare la mia vita passata, passo dietro passo, ed inserirsi nel mio presente, ora dopo ora, e necessitarmi il futuro.
Poggiare la testa sul suo petto ed aspettare, aspettare -sempre-.
Non so cosa.
E credere.
In lei, in me, in un sentimento capace di renderci uguali e di farci apparire gli altri diversi.
E l’appiattirsi di questa “infinita tristezza” che mi trascino da anni attraverso tante vanità.
Appiattirsi e scivolare fuori dal buco in cui la nascondo perché gli altri non la vedano e la deridano.
Sentirla sempre gioire come una bimba felice, palpitare
come l’onda serena della notte, insieme a me.
Tu che ormai sei più della mia coscienza, ora sai che, seduto accanto a te, per terra, le mani mie nei tuoi capelli, come adesso, anche solo per poco, dimentico finalmente che esiste quell’essere sentimentale e scettico, indifferente, balordo e vivo che sono io.
Copertine di Bruno Mancini
Ischia, Settembre 2022
INFO: 3914830355
dila@emmegiischia.com
COME I CINESI volume primo
Dedica – Introduzione
L’estate con la parrucca – Parte prima
Capitolo1°Capitolo 2°Capitolo 3°Capitolo 4°
L’estate con la parrucca – Parte seconda
Capitolo 1°Capitolo 2°Capitolo 3°Capitolo 4°Capitolo 5°Capitolo 6°>Capitolo 7°Capitolo 8°Capitolo 9°Capitolo 10°Capitolo 11°Capitolo 12°Capitolo 13°Capitolo 14°Capitolo 15°Capitolo 16°Capitolo 17°Capitolo 18°Capitolo 19°Capitolo 20°Capitolo 21°Capitolo 22°Capitolo 23°Capitolo 24°Capitolo 25°
Il Libro di Sonia
Capitolo 1Capitolo 2Capitolo 3Capitolo 4Capitolo 5Capitolo 6Capitolo 7Capitolo 8Capitolo 9Capitolo 10P.S.
Come i cinesi volume primo – L’ESTATE CON LA PARRUCCA – IL LIBRO DI SONIA
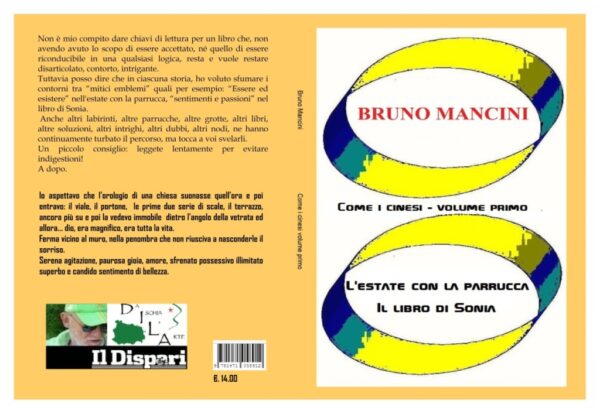
Come i cinesi volume primo
seconda edizione
ACQUISTA COM www.lulu.com
Come i cinesi volume primo
seconda edizione
ID ydp88k
ISBN 9781471058912
Bruno Mancini
ISBN 9781471058912
Versione 4 | ID ydp88k
Creato: 9 settembre 2022
Modificato: 9 settembre 2022
Libro, 142 Pagine
Libro stampato: A5 (148 x 210 mm)
Standard Bianco e nero, 60# Bianco
Libro a copertina morbida
Lucido Copertina
Prezzo di vendita: EUR 14.00

Titolo Come i cinesi – volume primo
Sottotitolo L’estate con la parrucca – Il libro di Sonia
Collaboratori Bruno Mancini
ISBN 9781471058912
Marchio editoriale Lulu.com
Edizione Nuova edizione
Seconda edizione
Licenza Tutti i diritti riservati – Licenza di copyright standard
Titolare del copyright Bruno Mancini
Anno del copyright 2022

Come i cinesi – volume primo
TESTO COMPLETO IN LETTURA LIBERA
seconda edizione
Racconti
L’estate con la parrucca
Il libro di Sonia
€ 14.00

